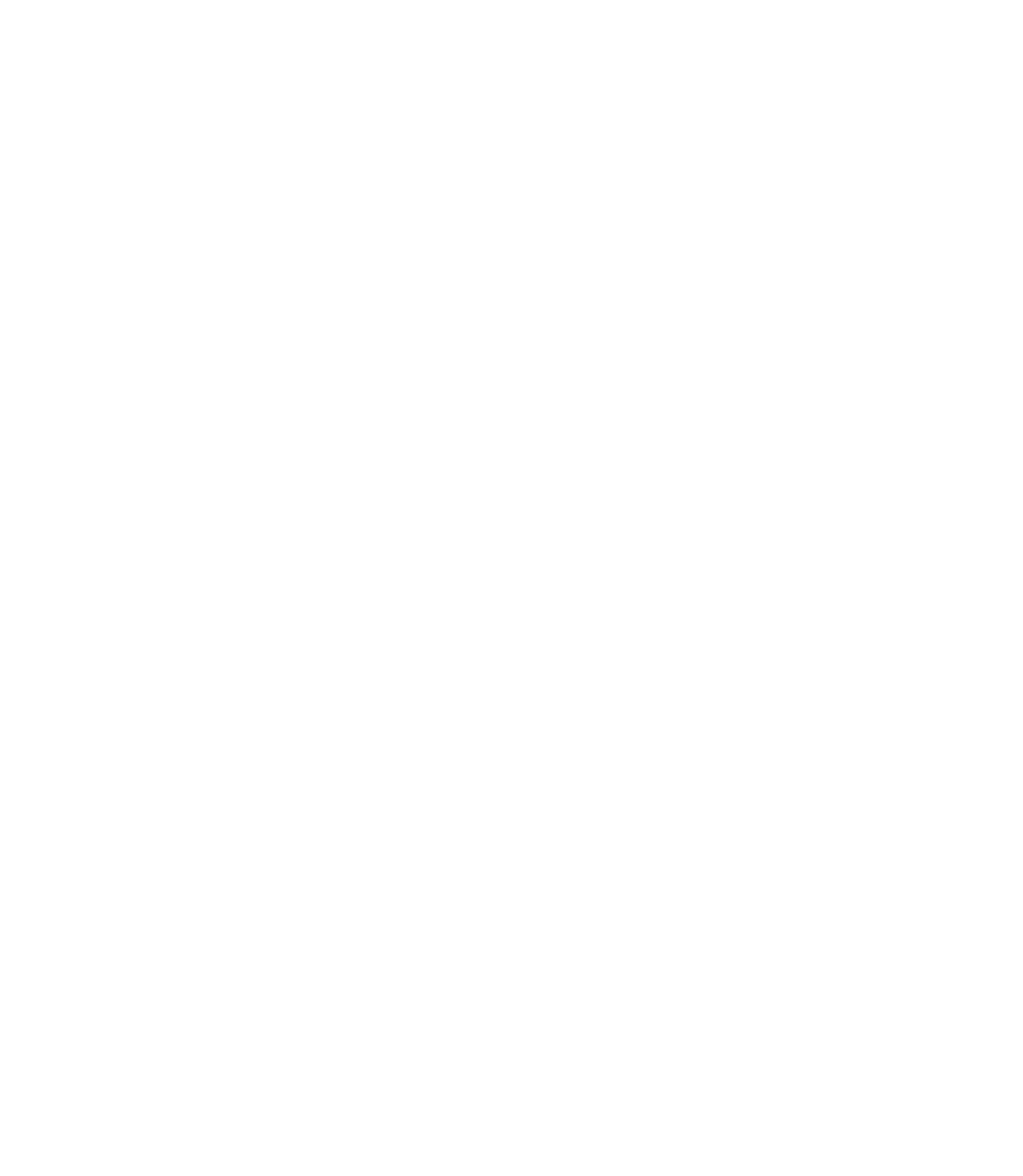15 Settembre 2025
Riforma delle sanzioni tributarie – 2 Focus sul “doppio binario retroattivo”
Sia la Corte costituzionale che la Corte Ue ritengono che il rispetto della lex mitior possa risultare recessivo e quindi derogabile nella comparazione con altri interessi
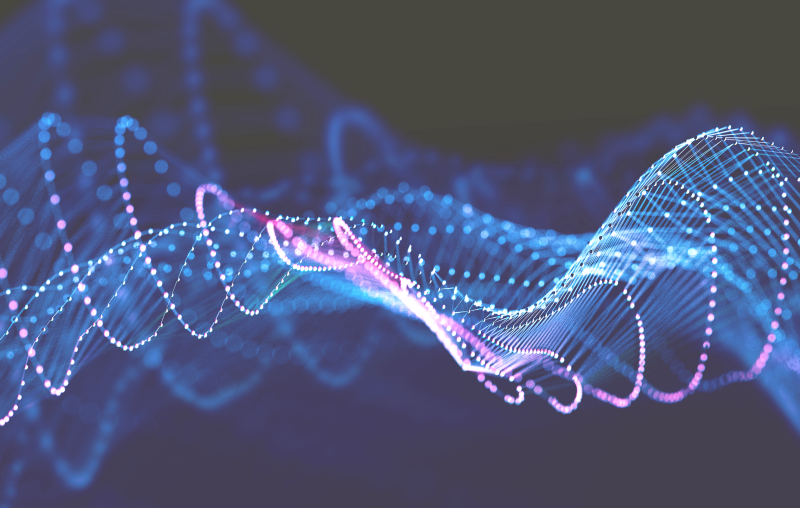
In questo secondo approfondimento vediamo più da vicino gli effetti e gli orientamenti giurisdizionali della mancata previsione, stabilita dall’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024, della retroattività della lex mitior, ossia del principio della retroattività penale secondo cui in caso di evoluzione normativa, a determinate condizioni è possibile beneficiare della pena più mite.
Le valutazioni della dottrina e dei contribuenti
La mancata previsione della retroattività della lex mitior ha destato sin da subito forti critiche da parte dei commentatori, che hanno sostenuto che l’articolo 5 del decreto, per come strutturato, presenti possibili profili di incostituzionalità. In particolare, è stata avanzata la tesi della lesione dell’articolo 25, comma 2, per violazione del principio di legalità/irretroattività, dell’articolo 3, per violazione del principio di ragionevolezza, e dell’articolo 76, per eccesso di delega.
La questione, peraltro, è già stata oggetto di specifici motivi avanzati di fronte ai giudici tributari, di ogni ordine e grado. E ha visto, in particolare, un deciso arresto delle critiche arrivare dalla Corte suprema di cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 (presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, consigliere estensore Francesco Federici).
La causa, instaurata su ricorso per cassazione della società contribuente, riguarda, nel merito, la tematica delle indebite le detrazioni Iva operate in relazione a fatture ricevute da varie agenzie di viaggio. Il ricorso di primo grado era stato rigettato, con decisione confermata presso la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.
In sede di legittimità, la società, tra l’altro, mediante memoria illustrativa, aveva anche invocato, in via gradata, l’applicazione dell’articolo 2 del Dlgs n. 87/2024, chiedendo la ridefinizione del carico sanzionatorio in misura del 70% dell’imposta oggetto di ripresa a tassazione. Ciò in applicazione del principio del favor rei, di cui all’articolo 3, comma 3 del Dlgs n. 472/1997. In particolare, nella memoria, la difesa della società aveva contestato la violazione dall’art. 3, comma 3, del Dlgs, n. 472/1997, e aveva denunciato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024 per eccesso di delega rispetto ai principi e alle direttive stabilite dalla legge n. 111/2023, nonché per violazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 6 e 7 Cedu e dell’articolo 49 Cdfue.
Secondo la parte, infatti, la mancata previsione della retroattività della norma più favorevole nell’ambito delle sanzioni amministrative tributarie avrebbe leso il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini, che in materia sanzionatoria imporrebbe il medesimo trattamento degli stessi fatti, prescindendo dalla loro commissione prima o dopo l’entrata in vigore della disciplina più favorevole.
Sulla base, poi, della contestata violazione delle norme sovranazionali, ha sostenuto che, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale, comunque invocata, l’articolo 5 debba essere disapplicato per contrasto con l’articolo 49, paragrafo 1, del Cdfue.
La decisione della Cassazione
La Corte suprema ha ritenuto non accoglibile la doglianza di parte.
In particolare, ha precisato che “la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”.
Secondo il giudice di legittimità, proprio l’ “ampio ripensamento della disciplina, come di tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal Legislatore con la L. n. 111 del 2023 […] consente di “leggere” la deroga alla lex mitior disposta dal legislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali, così come con quelli unionali”.
Sotto un primo aspetto, la Corte evidenzia che l’equivalenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale rappresenta sì una regola tendenzialmente ineludibile e inevitabile, ma che tuttavia la stessa non giunge a una perfetta sovrapposizione dei piani. Ciò in quanto “la stessa natura penale delle sanzioni ha necessità d’essere perimetrata”.
In questo senso, il richiamo non può che andare alla fondamentale sentenza “Engel” (Corte Edu, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others/Netherlands), che, nel valutare il profilo del ne bis in idem sanzionatorio tra piano amministrativo e piano penale, ha determinato una serie di criteri in base ai quali, in concreto (e giammai in astratto), la sanzione formalmente amministrativa può essere qualificata come sostanzialmente penale.
A tal fine, infatti, devono essere considerati, all’atto pratico, lo scopo afflittivo e non riparatorio della misura, la gravità della misura nella sua applicazione concreta, la rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore.
Pur nelle alterne vicende che hanno portato, di volta in volta, ad ampliare o restringere il campo di applicazione del ne bis in idem sanzionatorio, tale impostazione “in concreto e non in astratto” non è mai venuta meno.
Da ciò derivando che la sanzione amministrativa non può ritenersi coincidente con la pena per il reato. L’impossibilità di sostenere l’assoluta sovrapponibilità tra sanzione amministrativa e natura sostanzialmente penale fa cadere, sotto un primo punto di vista, la tesi secondo cui l’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024 violerebbe principi costituzionali.
Inoltre, secondo la Corte suprema, un altro elemento da tenere in considerazione sarebbe rappresentato dalla norma di salvaguardia presente nel comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 472/1997, il quale prevede che “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Ora, sebbene tale clausola sia direttamente riferita unicamente alla sopraggiunta non punibilità di una condotta, e benché il comma 3 del citato articolo 3 riguardi il diverso caso dell’applicazione della lex mitior senza stabilire un’analoga clausola, la Cassazione rifugge la tesi che il silenzio normativo escluda in radice eccezioni al principio del favor rei.
E, d’invero, posto che l’ipotesi di cui al comma 2 è ben più radicale di quella disciplinata dal comma 3, si dovrebbe dedurre che l’esclusione assoluta della derogabilità della lex mitior incontri, comunque, il medesimo limite sul piano logico. Sarebbe, infatti, irrazionale prevedere che una sanzione continui a essere applicata a fattispecie successivamente escluse dal regime sanzionatorio e contemporaneamente vietare la non retroattività della sanzione più mite. Naturalmente sempre in via di eccezione.
Un’interpretazione logica, coerente ed ermeneutica dei due commi induce, quindi, a ritenere derogabile anche il principio della retroattività della lex mitior.
Interpretazione che troverebbe copertura nei seguenti precedenti della Corte costituzionale:
- sentenza 16 aprile 2021, n. 68, la quale, richiamando anche altra sentenza della Corte – la n. 63/2019 – ha sostenuto che “la stessa Corte costituzionale ha equiparato le sanzioni amministrative di tipo afflittivo a quelle formalmente penali ai fini dell’applicazione del principio di retroattività della lex mitior: principio di minor forza rispetto a quello di legalità costituzionale. Nell’occasione, la Corte ha affermato che, laddove la sanzione amministrativa abbia natura punitiva, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicarla, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento: ciò, salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo vaglio positivo di ragionevolezza, alla cui stregua debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius”
- sentenza 21 marzo 2019, n. 63, ove la Corte costituzionale, rinviando anche alla precedente Sentenza n. 193 del 2016, ribadisce che il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” (ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior), può essere applicato unicamente alle sanzioni formalmente amministrative, che, in concreto, presentino natura e funzione “punitiva”. Ma ciò “salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di contro-interessi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo “vaglio positivo di ragionevolezza”, al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale”.
Secondo la Cassazione, poi, il riconoscimento della necessaria esistenza di ipotesi in cui il principio della lex mitior può essere derogato troverebbe riscontro anche nella giurisprudenza unionale. In tal senso cita la pronuncia assunta dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C107/2023, del 24 luglio 2023. In tale causa si discuteva dell’applicabilità retroattiva di forme di prescrizione del reato più favorevoli al reo. In tal caso la Cgue ha stabilito che “tenuto conto del necessario bilanciamento” con le “disposizioni dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF”, l’applicazione retroattiva delle nuove forme di prescrizione “deve essere considerata tale da compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione”[…] “Di conseguenza, si deve ritenere che i giudici nazionali non possano, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali diretti a sanzionare penalmente reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, applicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), come menzionato al punto 119 della presente sentenza, al fine di mettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituzionala (Corte costituzionale)”.
In definitiva, sia la Corte costituzionale che la Corte di giustizia appaiono ritenere che il rispetto della lex mitior possa risultare recessivo nella comparazione con altri interessi, con conseguente deroga.
La deroga al principio della lex mitior, in definitiva, secondo la Corte di cassazione, troverebbe il proprio fondamento nell’esigenza di comparazione con altri diritti di rango costituzionale o dell’Unione europea.
Passando dal generale al particolare, secondo il giudice di legittimità, l’irretroattività disposta dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 87/2024 (che detta previsioni complessivamente più favorevoli per il contribuente), si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rivisitazione dell’intero sistema sanzionatorio, sia qualitativo che quantitativo, in funzione del nuovo rapporto Fisco/Contribuente, valorizzando la condotta del Contribuente molto più rispetto a quanto avveniva nel passato.
Risulta quindi non accoglibile la tesi secondo cui l’unico effetto derivante dalla riforma delle sanzioni sarebbe rappresentato dalla mitigazione del carico afflittivo, senza valutare la riforma tributaria nel suo complesso, e come la riformulazione delle sanzioni si situi al suo interno.
La Corte, da ultimo, non dimentica di evidenziare come l’eventuale applicazione retroattiva della riduzione del carico sanzionatorio causerebbe effetti non trascurabili sulla possibilità di raggiungere prestazioni standard in materie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazioni sanitarie (articolo 32, Costituzione), scolastiche (articolo 34, Costituzione), di sicurezza pubblica, e così voi.
Parimenti carente di fondamento viene ritenuta la tesi secondo cui il più volte citato articolo 5 del decreto sarebbe incostituzionale per eccesso di delega del legislatore delegato. Anche sotto questo aspetto, secondo la Corte di cassazione, il legislatore delegato ha valutato la complessa revisione tributaria e tenendo presente i diversi valori e interessi di rilevanza costituzionale sottesi, agendo nel perimetro della delega conferita (articolo 22, legge 111/2023) disponendo tra l’altro che “I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria”.
Fine
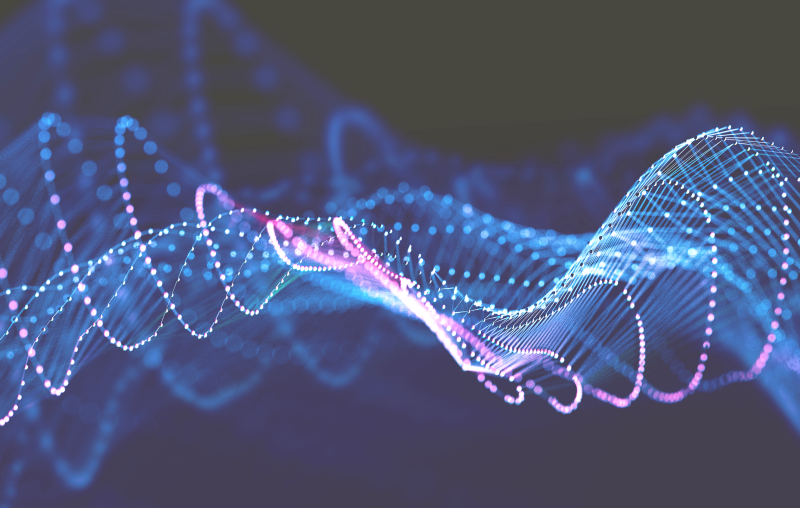
Ultimi articoli
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
Attualità 21 Gennaio 2026
Furto delle credenziali Spid: il phishing torna in azione
Alla vittima viene chiesto di inserire la password della propria identità digitale, mentre l’indirizzo mail è già precompilato tramite personalizzazione del link Una nuova truffa online cerca di sfruttare il logo dell’Agenzia delle entrate con l’intento di sottrarre le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) degli utenti.