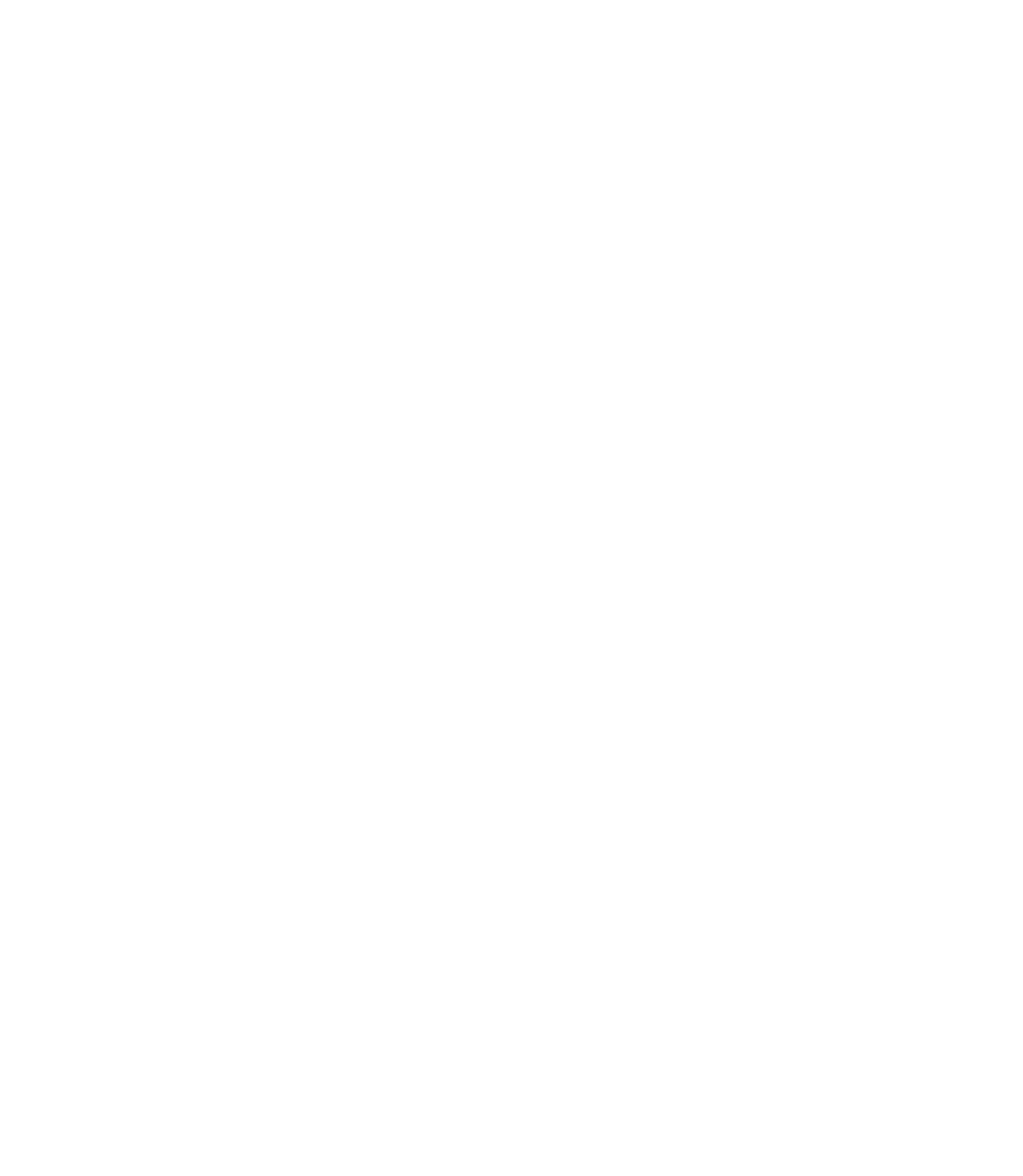12 Settembre 2025
Riforma delle sanzioni tributarie – 1 Focus sul “doppio binario retroattivo”
La revisione del sistema sanzionatorio si inserisce nella più ampia e organica riforma tributaria tesa a rimodulare il rapporto Fisco/Contribuente a favore di una maggiore compliance
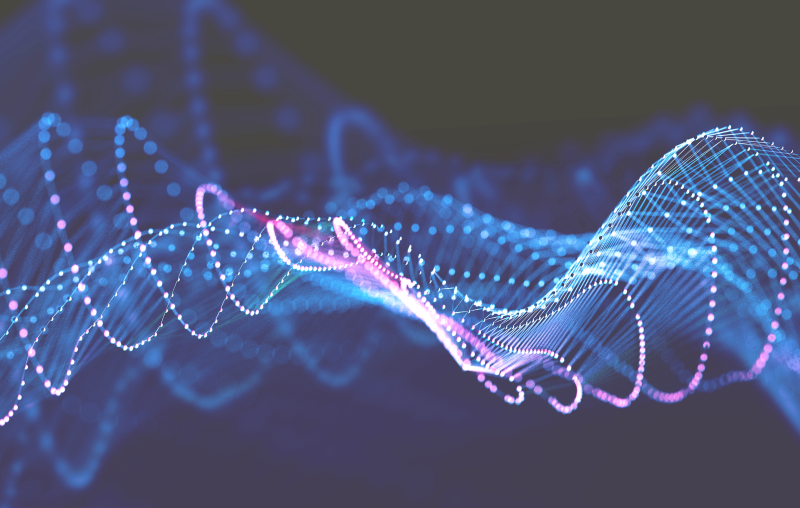
Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, in adempimento della legge di delega n. 111/2023 e, in particolare, dell’articolo 20 della delega stessa. Di seguito un approfondimento sulla retroattività o meno della nuova disciplina alla luce della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e dell’Unione europea.
La riforma e la struttura del decreto legislativo delegato
La legge delega ha fornito plurimi criteri direttivi, dando mandato al Governo di riformare il sistema sanzionatorio tributario ricercando, da un lato, il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni, e, dall’altro lato, la razionalizzazione del sistema sanzionatorio complessivo, declinabile nelle due accezioni amministrativa e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, e ponendo attenzione al principio del ne bis in idem e ai criteri unionali.
L’articolo 20 della legge n. 111/2023, peraltro, si situa nell’ambito di un’articolata legge di delega del sistema tributario complessivo, la quale è, nel suo insieme, protesa a instaurare un rinnovato rapporto Fisco-Contribuente, in cui la mitigazione delle sanzioni si collega al potenziamento degli interventi nell’ottica della prevenzione e della compliance dell’Amministrazione finanziaria, in una prospettiva in cui si mira a dare centralità alla resipiscenza del contribuente.
Il decreto legislativo n. 87/2024 è composto in totale di sette articoli; di questi, l’articolo 5 si occupa delle disposizioni transitorie e finali, il 7 dell’entrata in vigore. L’articolo 6 concerne le disposizioni finanziarie. In concreto, quindi, le disposizioni operativamente modificative del sistema sanzionatorio tributario sono contenute negli articoli da 1 a 4, che sono stati così strutturati:
- articolo 1 “Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali”. In particolare, la norma contiene modifiche al Dlgs n. 74/2000, inerenti sia i reati tributari sia il rapporto tra procedimento sanzionatorio amministrativo e penale; accoglie, inoltre, modifiche ad altre disposizioni che regolano le reciproche interconnessioni tra i due procedimenti incluse in diversi testi normativi ulteriori (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, Dpr n. 600/1973, Dpr n. 633/1972, Dpr n. 602/1973 e Dlgs n. 462/1997)
- articolo 2 “Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”
- articolo 3 “Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”
- articolo 4 “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti”.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, lo stesso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (sabato 29 giugno 2024).
Tuttavia, l’articolo 5 – “Disposizioni transitorie e finali” – prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Ne deriva che la riforma si applica a decorrere dal 29 giugno 2024 unicamente in riferimento ai reati tributari e alle norme che disciplinano i rapporti tra i due diversi ambiti sanzionatori. Diversamente, secondo quanto precisato dall’articolo 5, le modifiche alle disposizioni incidenti sulle sanzioni tributarie amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Relazione illustrativa e non retroattività della riforma in tema di sanzioni amministrative
Le possibili censure avanzabili nei confronti della scelta legislativa volta a determinare due diversi momenti di efficacia della novella e, soprattutto, diretta a stabilire l’irretroattività della riforma in punto di sanzioni amministrative tributarie erano ben note al Governo, che ha esposto i motivi a fondamento della scelta nella Relazione illustrativa che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere il 14 marzo 2024.
Nella citata Relazione illustrativa viene evidenziato che:
- la revisione del sistema sanzionatorio tributario deve essere interpretata e valutata nell’ambito di una più ampia e organica riforma tributaria demandata dalla legge di delega n. 111/2023. In tale contesto viene introdotta una nuova visione del rapporto Fisco/Contribuente, protesa a realizzare una maggiore compliance. In questa nuova visione s’inserisce anche la riforma delle sanzioni che, tuttavia, per essere razionale, deve rapportarsi alla struttura complessiva della riforma, ivi compresi i nuovi o modificati istituti sostanziali. In questa nuova declinazione del rapporto Fisco/Contribuente la riforma delle sanzioni viene a giocare un ruolo fondamentale, in quanto protesa a far coesistere la pervasività degli interventi anticipati dell’Amministrazione finanziaria (finalizzati a ottenere la compliance preventiva da parte dei contribuente), con il potenziamento degli istituti necessari a rendere effettiva l’applicazione della sanzione; il tutto nell’ambito di un approccio graduale nella determinazione delle sanzioni stesse. Dunque, la revisione del sistema sanzionatorio deve necessariamente coordinarsi e integrarsi con le modifiche sostanziali degli istituti volti alla contestazione, all’accertamento, al ravvedimento, alla definizione delle violazioni tributarie cui le sanzioni si collegano. In tal senso, il principio di ragionevolezza richiede che le modifiche al sistema sanzionatorio non possano essere scisse dal resto dell’impianto della riforma. Ciò a prescindere dal fatto che vi sia, giocoforza, uno sdoppiamento tra il momento di integrazione della violazione e il momento della contestazione del comportamento illecito e, ancor di più, dell’irrogazione della sanzione. Cosa che, tuttavia, avviene ora mediante i nuovi o riformati istituti sostanziali
- in via generale, e ricollegandosi al punto precedente, la giurisprudenza costituzionale già in passato ha rilevato la necessità di svolgere valutazioni di ragionevolezza che presentino un respiro sistematico. In questo senso, la Relazione illustrativa si richiama alla sentenza della Corte costituzionale n. 288/2019, la quale ha affermato che è “all’interno della considerazione di una revisione di sistema” che deve essere sviluppata la verifica della ragionevolezza delle norme che di tale complessiva revisione fanno parte, talché è “necessario considerare l’insieme degli interventi legislativi che hanno complessivamente accompagnato” quello di cui si discute, quando “deve essere collocato nel contesto di una riforma (anch’essa, per certi versi, di carattere sistemico) che ha prodotto significativi effetti”
- il principio della retroattività della lex mitior ha copertura costituzionale soltanto per le sanzioni di natura penale o sostanzialmente penale (articoli 3 e 117 della Costituzione, tramite cui trovano ingresso anche le varie fonti sovranazionali che lo contemplano, quali l’articolo 7 Cedu e l’articolo 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue). In questo contesto, la materia delle sanzioni amministrative, in generale e isolatamente considerata, non è sorretta dal principio di retroattività della lex mitior, salvo che alle sanzioni debba riconoscersi natura “sostanzialmente penale”. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 193/2016, ha chiarito che “la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina”
- è ben vero che in riferimento alla sanzione amministrativa tributaria opera l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 472/1997, in base al quale “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. Ma ciò non esclude che una norma successiva possa derogare a tale principio in presenza di adeguate e giustificate ragioni. Nessun dubbio si è posto sulla legittimità costituzionale di tale norma, né delle norme mediante le quali il legislatore successivo si è ragionevolmente avvalso della clausola derogatoria in questione (a tal proposito, si veda Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 6651/2016, paragrafo 3.3.)
- la giurisprudenza costituzionale, poi, riconosce come la regola della retroattività in mitius della legge penale medesima sia “suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli” (sentenza n. 236 del 2011)” (così, di recente, Corte costituzionale, n. 63/2019)
- oltre a quanto visto sopra, poi, la scelta in merito alla mancata retroattività della riforma sanzionatoria tributaria amministrativa corrisponde anche a un pubblico interesse costituzionalmente protetto, ossia l’interesse all’equilibrio del bilancio pubblico, costituzionalizzato all’articolo 81 della Costituzione. Sotto questo punto di vista, infatti, le sanzioni impattano sulle entrate previste per il bilancio dello Stato, con riferimento al contrasto all’evasione. Ne deriva che l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative ridotte previste da alcune delle norme del decreto avrebbe effetti sulle entrate e, correlativamente, avrebbe impatti negativi sul bilancio dello Stato. Per porre rimedio a una tale situazione sarebbe necessario, in ultima analisi, compensare il mancato incasso di parte delle sanzioni per comportamenti commessi nel previo sistema (ove l’irrogazione della vecchia sanzione era coerente e giustificata) addebitandolo in maniera diversa alla generalità dei consociati (anche in termini di minori servizi pubblici)
- tali considerazioni appaiono confermate anche dalla giurisprudenza interna costituzionale e in quella sovranazionale. La Corte costituzionale già in passato ha precisato che l’interesse costituzionalmente protetto all’equilibrio del bilancio pubblico è suscettibile di bilanciamento e prevalenza con altri valori costituzionalmente protetti. Nello stesso senso, in ambito unionale e con riferimento ai tributi armonizzati, è stato precisato che rientra tra le prerogative del legislatore compiere il necessario bilanciamento tra principi derivanti dalla Carta di Nizza e interessi di finanza pubblica (in questo senso, Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B)
- ne deriva che, dovendosi operare il bilanciamento di contrapposti valori costituzionali, l’interesse del soggetto responsabile di un comportamento costituente illecito amministrativo tributario a godere di sanzioni più miti trova bilanciamento nell’equilibrio di bilancio e nella necessità di non far gravare le minori entrate sulla generalità dei consociati, con impatti diversificati e maggiormente impattanti sulle fasce più deboli.
Continua
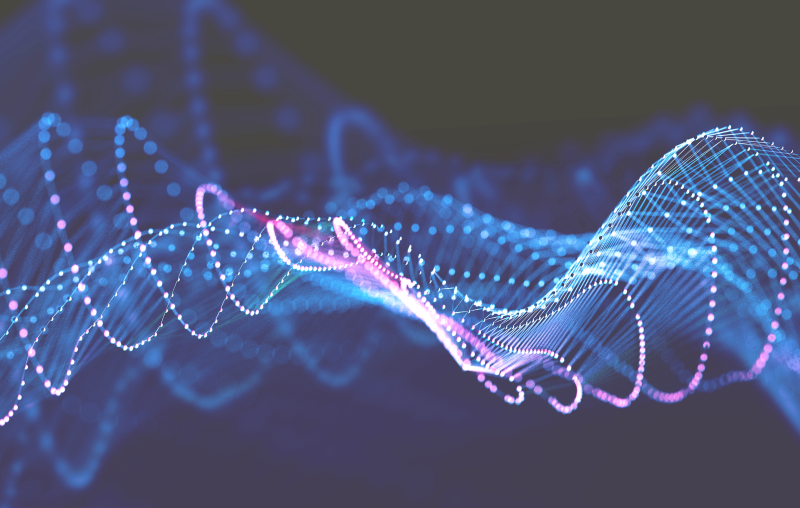
Ultimi articoli
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
Attualità 21 Gennaio 2026
Furto delle credenziali Spid: il phishing torna in azione
Alla vittima viene chiesto di inserire la password della propria identità digitale, mentre l’indirizzo mail è già precompilato tramite personalizzazione del link Una nuova truffa online cerca di sfruttare il logo dell’Agenzia delle entrate con l’intento di sottrarre le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) degli utenti.