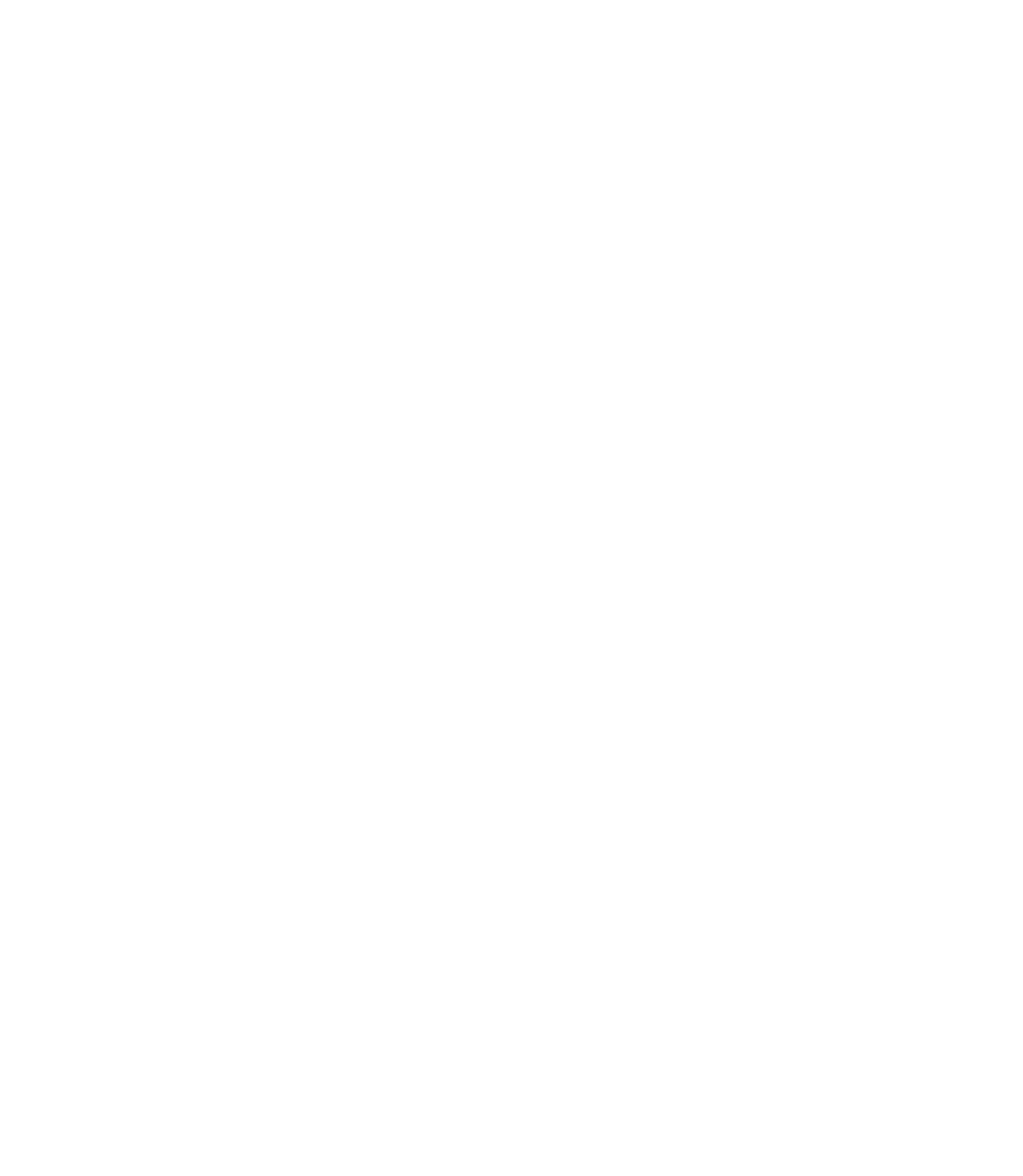1 Aprile 2025
Il giudizio per evasione fiscale: un papiro rivela antiche frodi
“Questo papiro è straordinario perché ci offre una visione diretta della preparazione dei processi in questa parte dell’Impero romano“, ha dichiarato la studiosa Anna Dolganov, dell’Accademia austriaca delle scienze. La storia delle frodi fiscali risale quindi a tempi antichissimi. Scorrendo i dettagli di questo papiro alcuni fenomeni come l’evasione fiscale, e gli schemi ingegnosi messi in pratica per realizzarla, sembrano non cambiare mai. Il documento, tradotto di recente e ritrovato nel deserto della Giudea, ci ha rivelato infatti come due intraprendenti cittadini romani dell’epoca, Gadalias e Saulos, avevano architettato una sorta di schema per eludere le imposte già nel 130 d.C. circa, in piena epoca imperiale, anche se il secondo risultava indigente. Naturalmente nelle loro finalità furono aiutati da diversi coprotagonisti, tra cui il principale fu Cherea, sorta di commerciante di schiavi. Obiettivo dell’impresa scudo o di comodo, creata in via momentanea e transitoria, stile apri e chiudi, era di non far figurare acquisti e vendite altamente lucrose di schiavi realizzate durante una visita dell’Imperatore Adriano. Risultato, meno tasse al fiscus imperiale. Ma perché durante una visita imperiale? Semplice, perché tali eventi moltiplicavano flussi di denaro e compravendite fornendo così nel clamore generale ampie possibilità agli evasori fiscali.
L’importanza di questo testo antico
Questo documento offre uno sguardo unico sulle istituzioni civiche locali e sul funzionamento dell’amministrazione e della giurisdizione provinciale romana nel Vicino Oriente. Inoltre, fa luce sulla questione del commercio e della proprietà degli schiavi e degli enormi flussi in denaro che scambi e compravendite comportavano.
L’evasione fiscale al tempo dei papiri
Se diamo per scontato che gli appunti del procuratore romano che descrive le astuzie dei due a giudizio fossero accurati, gli imprenditori Gadalias e Saulos erano abili nel falsificare le compravendite di schiavi per richiedere crediti d’imposta non dovuti e, al contempo, nel manipolare astutamente specifici documenti contabili per dimostrare di dover pagare tasse inferiori a quelle corrispondenti alla loro ricchezza effettiva. Quello che colpisce riguarda le tattiche elusive e gli escamotage per dribblare il fisco imperiale sono pressoché sovrapponibili alle frodi fiscali odierne, che vanno dalla manipolazione creativa dei bilanci aziendali all’uso di altri marchingegni.
Lo schema di evasione fiscale smascherato
In sostanza, includeva la vendita fittizia e la manomissione fraudolenta di documenti sulle compravendite di schiavi. Come? Un commerciante, di nome Cherea, acquistava schiavi per conto di Saulos e ne manometteva i documenti omettendone il cambio di proprietà, senza effettuare così i necessari pagamenti al fisco. In particolare, nel papiro si afferma che Saulos, in quanto indigente, era disposto a frodare il fisco. Di conseguenza, Saulos si servì di Cherea per acquistare schiavi a proprio nome (righi 50 e 51 del papiro), e comunque ne mantenne il possesso. In seguito, Saulos e suo padre riuscirono a ottenere la manomissione di un ulteriore documento di uno degli schiavi, evadendo ancora il fisco.
Schiavi e tasse
Essendo l’economia romana in prevalenza agricolo-commerciale a sfondo schiavile le tasse sulla vendita degli schiavi avevano ampia rilevanza: la prima testimonianza diretta della tassa romana del 4% sulla vendita degli schiavi, la cosiddetta quinta et vicesima venalium mancipiorum, si trova in un’iscrizione della metà del I secolo a.C. proveniente da Roma. Secondo Cassio Dione, questa tassa fu istituita da Augusto. Sia il resoconto di Cassio Dione che il termine publicum nelle fonti epigrafiche indicano che in Italia l’imposta era dovuta all’aerarium Saturni, mentre nelle province era presumibilmente riscossa dal fiscus. L’imposta era dovuta per ogni vendita di schiavi, indipendentemente dallo status giuridico dell’acquirente e del venditore, e i contratti di vendita rinvenuti menzionano esplicitamente il suo pagamento. Tra i “peregrini” dell’Oriente greco, la tassa in questione è indicata come “τέλος δούλου”, o ancora, come “ἐγκύκλιον ἀνδραπόδων”. Nell’Egitto romano, l’importo non sembra essere stato fissato al 4%, ma sembra aver variato tra il 4 e il 5%. Questo fa pensare che nelle Province imperiali il prelievo fosse più oneroso fino a variare a seconda dell’area geografica.
Le pene per chi evadeva il fiscus imperiale
A smascherare i due ci pensò un informatore che rivelò lo schema elusivo praticato da Gadalias e Saulos alle autorità romane. In realtà, le note del procuratore non indicano le motivazioni dell’informatore, ma potrebbe essere stato chiunque, da un ex socio d’affari scontento a qualcuno che cercava di ottenere una ricompensa o di ricevere il favore dei funzionari imperiali. Visto che, all’epoca, le sanzioni per casi di falsificazione dei documenti o frode fiscale potevano anche arrivare ad essere potenzialmente brutali, è anche possibile che l’informatore partecipasse anche lui allo schema elusivo e che rivelando i nomi dei due imprenditori, e i dettagli della frode fiscale ai danni del fiscus imperiale, sperasse di ottenere un accordo di favore in cambio di informazioni. Le leggi romane sulla falsificazione e sulla frode fiscale erano davvero severe. A differenza di oggi, gli evasori fiscali romani potevano essere esiliati, giustiziati o condannati al lavoro nelle miniere, che in realtà equivaleva a una effettiva condanna a morte viste le condizioni di chi vi lavorava, in maggioranza schiavi.
Le pene romane in punta di diritto
Nel diritto romano, la falsificazione di documenti (falsum) era un reato pubblico che rientrava nelle disposizioni della lex Cornelia testamentaria nummaria tardo-repubblicana, nota anche come lex Cornelia de falsis. Inizialmente, questa legge si applicava ai testamenti e ad altri documenti muniti di sigillo, come le dichiarazioni dei testimoni e i registri pubblici, ma in seguito estese il suo ambito di applicazione alla falsificazione, alla manipolazione, alla rimozione o alla distruzione di molti tipi diversi di documenti alla base di rivendicazioni legali. La lex Cornelia puniva anche l’uso di tali documenti falsi o manipolati. Era comunque prevista anche l’amnistia ma poteva essere concessa solo per i casi di ignoranza o errore in buona fede.
Ieri/oggi, le tattiche per eludere il fisco
È notevole che per millenni si sia cercato di eludere le tasse ricorrendo alle stesse tattiche e strategie di base pressoché immutabili: falsificare le transazioni, intestare dei patrimoni a dei prestanome e sperare di farla franca. In epoca imperiale le sanzioni contro le frodi fiscali erano molto dure. Infatti, non si limitavano al semplice pagamento dei danni, ma acquisivano una dimensione punitiva e potevano comportare pesanti multe e la confisca dei beni per poi passare a vere e proprie condanne estremamente severe come codificato nella lex Cornelia.
La fonte di questo articolo è lo studio Forgery and Fiscal Fraud in Iudaea and Arabia on the Eve of the Bar Kokhba Revolt: Memorandum and Minutes of a Trial before a Roman Official (P. Cotton) di Anna Dolganov, Fritz Mitthof, Hannah M. Cotton e Avner Ecker.

Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.